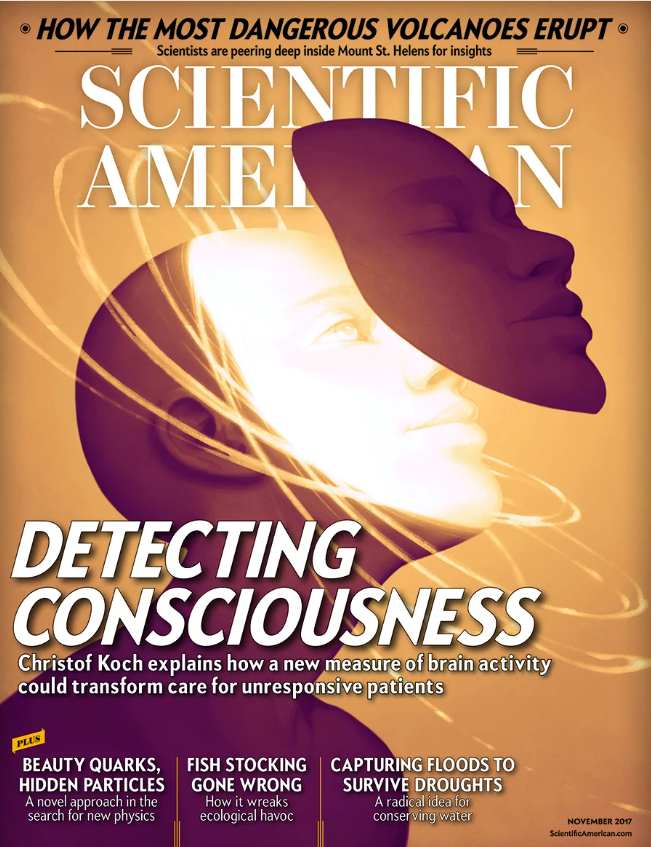
Partiti da una definizione teorica della coscienza, legata alla capacità del cervello di creare schemi di funzionamento complessi, i ricercatori del DIBIC di Milano coordinati da Marcello Massimini hanno realizzato uno strumento in grado di leggere la risposta cerebrale a uno stimolo magnetico, per misurare la presenza di complessità. Questo metodo serve a stabilire se pazienti che emergono dal coma in uno stato di veglia non responsiva, incapaci di interagire con il mondo esterno, sono in realtà coscienti. Già utilizzata in alcuni centri, la nuova metodica risponde a fondamentali esigenze cliniche, riabilitative ed etiche.
Il paziente è disteso nel letto, incapace di muoversi e di parlare. Non risponde agli stimoli. La causa del suo stato è una grave lesione cerebrale, che può avere avuto diverse origini: un trauma, oppure un’anossia cerebrale – ovvero un’interruzione dell’apporto di sangue e quindi di ossigeno alle cellule cerebrali – dovuta a un infarto o a soffocamento, oppure un’infezione, come un’encefalite o una meningite.
Sopravvissuto alla fase di emergenza grazie alla terapia intensiva, il paziente è ora uscito dal coma e fuori pericolo di vita, ma è incapace di reazioni volontarie. Non muove la mano se gli viene chiesto, non segue con gli occhi (anche quando sono aperti) una persona che passa per la stanza. Comunicare con lui sembra essere impossibile.
Si parla per questi casi di “veglia non responsiva” o più comunemente di stato vegetativo: sembra che nel cervello del paziente siano state risparmiate solo le attività del tronco encefalico, ovvero di quella parte del cervello che controlla processi fondamentali del nostro organismo, come la respirazione, la regolazione del circolo sanguigno, la transizione sonno-veglia, i movimenti oculari spontanei.
Si tratta di una condizione – che può durare giorni, mesi o anni – paradossalmente legata ai grandi successi della medicina d’emergenza moderna, che con la terapia intensiva riesce a strappare al coma persone che hanno sfiorato la morte, destinate, fino a qualche decennio fa, a non sopravvivere ai gravi danni subiti dal cervello.
L’evoluzione delle procedure di rianimazione e in particolare l’invenzione della ventilazione meccanica, che insieme alle moderne terapie farmacologiche consente di mantenere i parametri vitali anche nelle fasi più acute del coma, ha fatto sì che oggi si sopravviva in misura enormemente maggiore di quanto avveniva anche solo cinquant’anni fa. In molti casi, si esce dal coma e si sopravvive per essere restituiti alla salute e a una vita normale o quasi. In altri casi restano disabilità più o meno gravi. In altri ancora si rimane costretti a letto, privi di coscienza. Dipende dall’entità dei danni subiti dal cervello nella fase traumatica e dalla loro evoluzione. Questo problema è cruciale, poiché una diagnosi corretta può cambiare drasticamente il percorso riabilitativo di questi pazienti, alcuni dei quali potrebbero avere una coscienza “nascosta” e quindi prospettive di recupero migliori.
Si occupa proprio di questi pazienti il DIBIC, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano, sotto la guida di Marcello Massimini, docente di Neurofisiologia Umana, in collaborazione con altre istituzioni internazionali come la Università del Wisconsin e il ComaScience Group di Liegi.
Il gruppo di ricerca ha sviluppato una metodologia che misura la complessità dell’attività cerebrale tramite un sistema di rilevamento basato sulla stimolazione magnetica transcranica (TMS) combinata con l’elettroencefalografia ad alta densità (HD-EEG). Questa tecnica permette di rilevare risposte cerebrali complesse, indice della presenza di coscienza anche in pazienti non in grado di rispondere agli stimoli esterni.
L’approccio innovativo proposto si fonda sulla capacità del cervello di integrare e differenziare una grande quantità di informazioni, generando una risposta complessa, che è vista come una caratteristica chiave della coscienza. La complessità della risposta cerebrale viene quantificata attraverso il Perturbational Complexity Index (PCI), che esprime la capacità del cervello di generare attività complesse. Questo indicatore ha dimostrato la sua validità sia in condizioni di coscienza (come nel sonno con sogni o in stati allucinatori), sia di incoscienza (come nel sonno senza sogni o sotto anestesia).

Un risultato chiave della ricerca è che circa il 20% dei pazienti in stato vegetativo ha mostrato livelli di complessità cerebrale compatibili con la presenza di coscienza, suggerendo la possibilità di recupero della comunicazione con l’ambiente esterno se sottoposti a trattamenti riabilitativi intensivi. Questo ha portato a un cambiamento nelle linee guida internazionali per la diagnosi e la cura dei pazienti in coma e ha aperto la strada a nuove applicazioni cliniche e progetti di ricerca in tutto il mondo.
Il gruppo lavora per lo sviluppo ulteriore della metodica nell’ambito di vasti progetti collaborativi internazionali, tra cui la flagship europea Human Brain Project e il progetto multicentrico americano Measuring Consciousness from theory to practice finanziato da Tiny Blue Dot Fundation, progetti in cui il gruppo partecipa con un ruolo scientifico preminente. Quest’ultimo in particolare prevede il finanziamento, con prospettiva decennale, di uno studio multicentrico su pazienti con gravi lesioni cerebrali che, guidato dall’Università degli Studi di Milano, coinvolge l’Harvard Medical School, il Massachusetts General Hospital, la University of California Los Angeles, la Medical University of South Carolina e la University of Wisconsin.
In questo ambito, il gruppo della Statale di Milano ha stretto a livello locale una solida convenzione con la IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ed in particolare con il reparto per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite, il cui primario è Jorge Navarro, dove la metodica è regolarmente utilizzata per la valutazione dei pazienti, con il coordinamento della neurologa Angela Comanducci. La nascita di questo nuovo reparto, aperto nel 2018, è avvenuta sotto la guida scientifica di Marcello Massimini (responsabile scientifico) e Silvia Casarotto, docente dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito di una convenzione di ricerca tra l’Università e la Fondazione, che realizza un connubio unico tra scienza e clinica e rappresenta la prima struttura disponibile a Milano per la diagnosi, l’inquadramento e la riabilitazione dei pazienti con grave cerebrolesione.
Il metodo sviluppato non solo ha implicazioni cliniche per la gestione e il trattamento dei pazienti con gravi lesioni cerebrali, ma è anche rilevante per la ricerca, in quanto permette di indagare i meccanismi di recupero della coscienza. Il team di ricerca sta espandendo i propri studi per capire come intervenire sui pazienti che non mostrano segni di recupero, cercando di “risvegliare” le parti del cervello intatte ma inattive.
Il potenziale futuro di questo metodo per l’uso clinico su larga scala si sta spiegando grazie alla collaborazione con la compagnia finlandese Nexstim, che sta sviluppando gli strumenti necessari per la stimolazione magnetica e la neuronavigazione. Un clinical trial multicentrico è in fase di progettazione, e la creazione di una spin-off, Intrinsic Powers, mira a sviluppare ulteriormente la tecnologia per renderla accessibile in contesti ospedalieri in tutto il mondo.
Il lavoro del DIBIC rappresenta dunque un passo avanti significativo non solo nella comprensione scientifica della coscienza, ma anche nelle sue applicazioni pratiche in campo medico, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti con lesioni cerebrali gravi.
Vuoi saperne di più? Leggi il capitolo “Leggere il cervello per misurare la coscienza” del volume Stimolare l’innovazione, inventando nuovi strumenti e metodi, a cura di Luca Carra, Natalia Milazzo, Massimo Bianchi, disponibile sul sito di Milano University Press.
